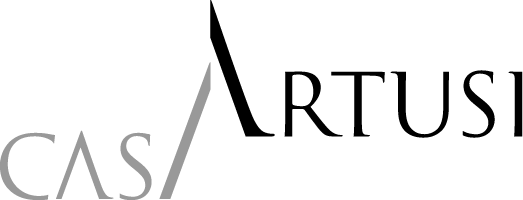Ada Boni vs Pellegrino Artusi
- Data
Come potete immaginare, Pellegrino Artusi non ha avuto solo degli estimatori. Il padre della cucina italiana moderna, ha dovuto subire prima l’indifferenza degli editori che ne hanno rifiutato il manoscritto, poi le critiche di altri gastronomi che mettevano in dubbio la qualità del suo lavoro.
In particolare, l’opposizione più forte e plateale arriva da un’altra grande scrittrice, anzi forse l’unica gastronoma destinata a prendere il posto nel cuore degli italiani con Artusi, nelle loro cucine e sulle loro librerie: Ada Boni.
Meglio conosciuta come l’autrice del Talismano della felicità, pubblicato per la prima volta nel 1925, Ada Boni nasce nel 1881 a Roma come Ada Giaquinto. Se questo nome vi suona familiare non è un caso: lo zio paterno era nientemeno Adolfo Giaquinto, autore di cucina tra i più illustri della sua epoca.
La sua è una famiglia benestante, condizione che sarà consolidata con il matrimonio con Enrico Boni, figlio di orafi romani, nonché scultore, pittore, scrittore, e appassionato di cucina, nonché amico personale di Auguste Escoffier. A Roma la coppia abita nel magnifico Palazzo Odescalchi che, in breve, diventa uno dei salotti buoni della borghesia romana.
Il giudizio tagliente riguardante Artusi appare nella prefazione del Talismano, affidata al marito Enrico Boni. Innanzitutto vengono passati in rassegna alcuni ricettari di metà Ottocento come il Trattato di cucina di Giovanni Vialardi (vera autorità in materia, nonché cuoco della casa reale) e Il Re dei cuochi di Giovanni Nelli. Entrambi giudicati ricettari eccellenti, ma colpevoli di una «decrepita fastosità» che non si addice alla cucina moderna.
Altro autore citato è, ovviamente, Adolfo Giaquinto la cui produzione è molto più recente e si colloca nel primo ventennio del Novecento. L’opinione su di lui è estremamente indulgente e non poteva essere altrimenti per lo zio che aveva introdotto la piccola Ada alla professione gastronomica. A lui si contesta solo la «sensibile ed evidente tendenza alla ricchezza di preparazioni». Tutto sommato un peccato veniale.
L’attacco al vetriolo è invece riservato al gastronomo forlimpopolese che riportiamo per intero:
«L’autore che riuscì invece a vendere stracci e orpelli per sete rare e oro fu Pellegrino Artusi, nume custode di quelle famiglie dove non si sa cucinare. Per taluni tutto ciò che dice l’Artusi è vangelo, anche quando questo ineffabile autore scrive con olimpica indifferenza le sciocchezze più madornali. Anzitutto egli dichiara di essere un dilettante e di aver provato le sue ricette alla sazietà, fino a che gli riuscirono bene, o meglio sembrò a lui che riuscissero tali. Egli fa un edificante preambolo che suona presso a poco così: Guardate, io non so cucinare, tanto vero che i cuochi preparano le ricette che io insegno in un modo completamente diverso. Però dopo una serie di tentativi sono riuscito ad ottenere qualche risultato, ed anche voi, un po’ con la mia guida (!) un po’ con la vostra pazienza, può darsi che riusciate “ad annaspar qualche cosa”.
Ed allora verrebbe voglia di chiedere a questo signor Artusi perché mai stando le cose così, egli si mise ad insegnare una disciplina di cui non conosceva neanche i principii. Il guaio è che, fedele alle premesse, l’Autore non esita nel suo volume – che infiora di aneddoti di uno spirito irresistibile – ad esporre delle ricette in aperta antitesi con i canoni fondamentali dell’arte della cucina. Denominazioni cervellotiche, traduzioni italiane di parole tecniche francesi da far accapponare la pelle, evangelica dosatura delle ricette – c’è ad esempio un pasticcio per 20 persone preparato con mezza lepre – assoluta irrazionalità di procedimenti: tutto questo, ed altro ancora che all’occorrenza potremmo esaurientemente documentare, fanno del volume in questione un’opera unica nel suo genere, che potrebbe definirsi l’umoristico capolavoro della incompetenza culinaria. Ma anche questo, che potrebbe chiamarsi “il fenomeno Artusi”, e che costituì una colossale montatura a chi sa perché si prestarono in piena buona fede anche delle persone intelligenti…»
L’astio nei confronti di Artusi è totale e, per molti aspetti, fuori luogo, in quanto è un’aperta critica a un autore ormai deceduto da 16 anni. Proprio per questo motivo è ancora più sorprendente e vale la pena approfondirne le cause.
Come prima cosa bisogna dire che il giudizio di mancata professionalità indirizzato ad Artusi non regge. Dopotutto erano entrambi sullo stesso piano e, a differenza di altri autori, nessuno dei due aveva intrapreso una carriera da cuoco.
Non è possibile nemmeno che l’attrito fosse scatenato dalla differenza di estrazione sociale, visto che entrambi facevano parte di quella borghesia agiata -l’uno a Firenze, l’altra Roma- da cui pescano a piene mani per le loro ricette.
A bene vedere c’erano molti più punti in comune di quanti Ada Boni fosse disposta ad ammettere. L’unica vera differenza e motivo della censura è in realtà una questione generazionale.
Artusi era di sessant’anni più vecchio di Ada Boni e, nonostante l’impianto innovativo del suo ricettario, i suoi piatti mantengono un’impostazione pienamente ottocentesca. La scrittrice romana è invece immersa nella cultura novecentesca, quella dei ruggenti anni venti, proiettata verso una cucina pratica, veloce ed economica.
Può sembrare assurdo, ma Ada Boni non riconosce nemmeno i meriti di Artusi in termini generali per essersi affrancato dall’imperante cultura francese e nega perfino l’importanza del ricettario come apripista di una serie di pubblicazioni culinarie, inclusa la sua.
Il fatto è che, nei trent’anni che separano la prima edizione dell’Artusi e il ricettario di Ada Boni, l’Europa era stata sconvolta da un conflitto mondiale e il tempo si era improvvisamente accelerato. La cucina aveva il dovere di stare al passo.
Le ricette della Scienza in cucina, sembravano improvvisamente lontane, appartenenti a un’altra epoca, Il Novecento non è stato solo il Secolo breve riprendendo il celebre saggio di Eric Hobsbawm, ma anche il “secolo veloce”, dove l'intera società aveva subito un traumatico balzo in avanti.
Ce ne accorgiamo prendendo in considerazione un episodio piuttosto simile, accaduto sempre in campo gastronomico qualche anno più tardi. Si tratta della recensione del libro Gli italiani a tavola di Felice Cunsolo da parte di Luigi Veronelli nel 1959 sulla sua rivista Il gastronomo. Anche stavolta l’attacco sferzante non risparmia il ricettario dove, secondo il critico milanese, gli errori «spuntano a plotoni»
In questo caso viene tirata in ballo la preparazione dell’amatriciana che, a dire di Veronelli, è completamente sbagliata. Cunsolo, da canto suo, si difende dalle critiche, chiamando a sua difesa altri libri che riportano la stessa versione: la Guida gastronomica d’Italia del Touring Club Italiano (1931), il Cucchiaio d’argento (1950) e Il Talismano della felicità (1925). Per tutta risposta, Veronelli ribatte «Lei mi cita tre testi, caro Cunsolo, la cui autorità ben mi guardo dal riconoscere, ottimo il primo per il turista, buoni gli altri due per le massaie, nessuno per i gastronomi». Stavolta la critica tocca al Talismano della felicità, bollato come libretto buono per le massaie, ma senza alcun valore.
Nella redazione del suo trattato di cucina, Felice Cunsolo si era limitato a riprendere vecchie ricette e riportarle così com’erano, senza sottoporle ad alcun aggiornamento. Nel frattempo, di nuovo, il mondo aveva conosciuto un secondo conflitto, più devastante del primo e l’Italia stava conoscendo i primi esiti del boom economico.
L’amatriciana di Felice Cunsolo, ripresa da Ada Boni, non era sbagliata in sé, ma semplicemente era una ricetta che non veniva più riconosciuta come rappresentativa della cucina romana dell’epoca. Semplicemente la tradizione si era aggiornata.
Si continuavano, è vero, a invocare i piatti delle mamme e delle nonne, le antiche origini e le antichissime origini, ma con contorcimenti e capriole tali che non sarebbero sopravvissuti a qualsiasi indagine storica.
Nel giro di un trentennio i vecchi manuali erano già diventati inutili e i gastronomi erano chiamati come testimoni del proprio tempo.
A pensarci, non è cambiato molto nemmeno oggi e basta sfogliare un ricettario o una rivista di trent’anni fa per accorgersene.